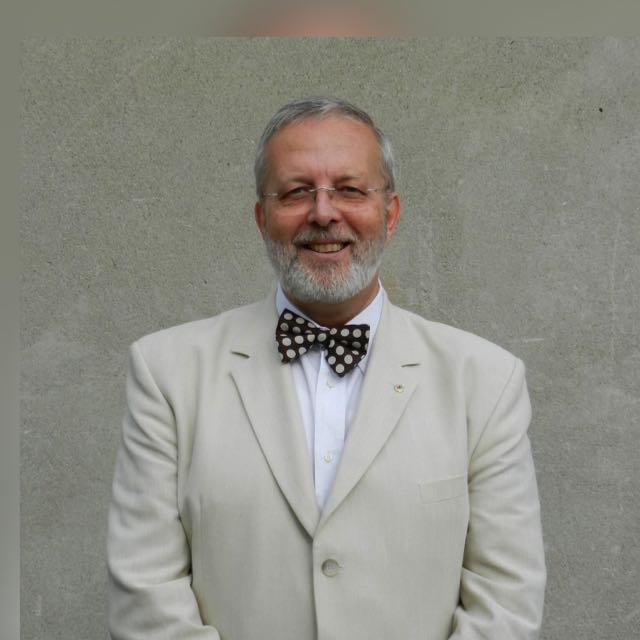“La Costituzione la teniamo…la cambiamo?” Docente Giuseppe Niedda mercoledì
18 gennaio 2023 ore 15,30 -17,00 Conferenze UNITRE’ di Cuorgnè presso ex chiesa della SS. Trinità –Via Milite Ignoto
L’emerito onorevole avvocato Giuseppe Niedda ci parlerà se la nostra Costituzione è ancora attuale ma ancora poco realizzata. La Costituzione è nata nel 1948 è entrata in discussione con l’inizio degli anni 70 dello scorso secolo, quando si è cominciato a parlare di “Repubblica da riformare”, per poi riacquistare nuova vita in funzione della delegittimazione di una parte dello schieramento politico. Il docente ci parlerà delle sue origini, sulle sue debolezze, sulle debolezze di quelli che ne hanno rifiutato alcune parti. Insomma, non c’è solo da esaminare la nota asimmetria tra lungimiranza della prima parte, la Costituzione presbite, e debolezza della seconda parte, la Costituzione miope, ma anche da considerare le origini culturali delle varie parti, le norme che dovevano essere scritte nella Costituzione, quelle poi rifiutate, quelle, infine, dimenticate. Precisiamo che la prevista conferenza: “La grammatica della trasfigurazione”. La bellezza di Dio nell’arte cristiana. Verrà tenuta dal docente Don Alexandru Rachiteanu, Mercoledì 1 FEBBRAIO 2023 ore 15,30 -17,00
Buona giornata. Ogni giorno viviamo con quelli che ci possono rendere migliori e che noi possiamo rendere loro migliori. C’è un vantaggio reciproco perché gli esseri umani mentre insegnano, imparano. Felice martedì
Donare il sangue è donare vita!
L’atto del donare il sangue è anonimo, gratuito e generoso. Il donare gratuitamente il sangue è la sua sacralità. Non si paga la vita, si dona gratuitamente, ma una ricompensa forse maggiore c’è, il sentimento aver fatto del bene con un grande gesto di solidarietà. Questo lo avvertiamo dentro di noi quando doniamo e quando riusciamo a diffondere il messaggio e a promuovere il dono. Mi sono commosso quando durante una delle ultime donazioni, una ragazza mi ha raccontato che veniva a donare perché suo sonno donava il sangue e così sua madre. Mi ha colpito di come donava allora suo nonno, lui su un lettino con l’ago nel braccio dava e l’altro in un lettino a fianco con l’ago del braccio a riceveva, la donazione diretta. la ricompensa che riceviamo è quella di aver fatto la giusta azione, di essere degli eroi nel quotidiano. perché il sangue non è riproducibile artificialmente ed è indispensabile alla vita. Il suo fabbisogno è in costante crescita: molte cure non sarebbero possibili senza la disponibilità di unità di sangue, di plasma e piastrine. La disponibilità del “bene sangue” dipende da un dono volontario e gratuito. Donare sangue è una scelta di solidarietà e civiltà: la disponibilità di sangue è un patrimonio collettivo di cui ciascuno può usufruire al momento del bisogno. Il sangue è una fonte di vita rinnovabile: lo si può donare regolarmente senza alcun danno perché l’organismo lo reintegra molto velocemente. Per donare sangue bisogna avere almeno 18 anni, pesare più di 50 Kg, essere in buone condizioni di salute e condurre uno stile di vita senza comportamenti a rischio. Per le donazioni di sangue intero, se non sia ha mai donato occorre non avere superato i 60 anni, per donatori periodici il limite è di 65 anni. Se interessati alla donazione Vi aspettiamo a Favria cortile interno del Comune, potete prenotare l’eventuale prelievo al numero di cell.3331714827, oppure tramite la mail favria@fidasadsp.it.
Vi aspettiamo mercoledì 18 gennaio ore 8,00 -11,20 cortile interno del Comune di Favria, Favria, 18.01.2023 Giorgio Cortese
Buona giornata. Ci sono due modi per vivere la vita, il primo è quello di pensare che non ci siano miracoli, l’altro è pensare che ogni cosa sia un miracolo. Felice mercoledì.
Nowo Postojalowka, il martiro degli Alpini 19-20 gennaio
Tutto ebbe inizio lo sventurato 10 giugno 1940, quando gli Alpini delle nostre terre furono impegnati in Francia, Albania, Jugoslavia, Grecia; poi nell’estate 1942 nella Russia immensa in appoggio ai tedeschi e allo CSIR italiano già presente laggiù. Preparativi affrettati, sgomento alle partenze delle tradotte che, attraverso la desolazione di Austria e Polonia, approdarono a un altro mondo, sconvolto e sconfinato. Le Divisioni “Cuneense”, “Julia” e “Tridentina” avevano sentito parlare dei monti del Caucaso, invece furono avviate con marce sfiancanti verso le pianure del Don: un fronte di 75 chilometri da presidiare. Insidie già in agosto; a ottobre prima neve, primi congelamenti e attacchi difficili da ricacciare coi vecchi fucili ‘91. A metà dicembre, azioni russe in profondità; primi cedimenti e rischi d’accerchiamento. A Natale, reparti del “Mondovì”, del “Ceva”, del “Saluzzo” sono sotto attacco, mentre ripiegano i tedeschi che sono con loro. Il 15 gennaio ‘43 poderosi carri armati russi puntano su Rossosch, e il comando deve spostarsi a Postojaly, mentre i duemila uomini rimasti a Rossosch col gen. Martinat vengono cannoneggiati. La Cuneense e la Julia sono provati negli effettivi da combattimenti e nella ritirata verso nord-est. Poi per tutti avviene il ripiegamento generale il 17 gennaio, in un clima di confusione con ostacoli di autocarri a secco di carburante, rifornimenti impossibili, zaini abbandonati. La “Cuneense” punta su Popowka nel buio e nel vento gelido: spera di raggiungere Waluiki prima che la strada sia sbarrata. E qui tra il 19 e 20 gennaio 1943 nell’ambito dell’offensiva Ostrogozsk-Rossos, si svolse il più rilevante scontro armato, per reparti impegnati e per numero di caduti, fra le divisioni alpine in ritirata e l’Armata Rossa. Nella piccola località di Nowo Postojalowka le divisioni Julia e Cuneense, due delle tre unità che componevano il Corpo d’Armata Alpino, giunsero nel pieno della fase di ripiegamento dalle posizioni che occupavano sul fiume Don, dopo lo sfondamento dei sovietici nel settore tenuto dalle truppe tedesche e ungheresi. Qui le nostre divisioni, già duramente provate dalla fatica, dal freddo e dalla fame, si trovarono a combattere contro un nemico superiore in uomini e armi. Dalle isbe presso il villaggio di Nowo Postojalowka sbucano bocche di cannoni dai colpi micidiali. Strisciando nella neve, gli Alpini raggiungono i margini del paese, poi si lanciano allo scoperto contro i carri. Molti di loro cadono o e vengono catturati. Inutilmente i comandanti, il colonello Manfredi del “Mondovì”, il generale Battisti e poi il generale Ricagno della “Julia”, chiedono appoggi per tentare d’aprire un varco prima che i russi ricevano rinforzi. Allora le truppe alpine si lanciano in un disperato assalto contro i russi sotto un fuoco intenso. I carri armati russi avanzano implacabili. In testa ai superstiti del “Ceva”, si lanciano contro dei carri armati fucili e bombe a mano, e tutti lottano anche all’arma bianca. I russi si asserragliano nel paese, e gli alpini non passano. Nella neve, morti, feriti, relitti. Allora il generale Battisti ordina al generale Manfredi di bruciare la bandiera del “Mondovì” perché non cada in mano nemica. Con il sopraggiungere della notte la cruenta battaglia si spegne. La “Cuneense” è più che dimezzata, e riceve l’ordine di “sganciarsi dalla morsa” tentando d’aggirare nel buio il villaggio per puntare su Postojali nella speranza che, intanto, sia stata liberata dalla “Tridentina”. Ma si devono abbandonare feriti e congelati. I loro gemiti e le loro invocazioni feriscono più delle cannonate. Questa è la battaglia di di Nowo Postojalowka, avvenuta tra il 19 eil 20 gennaio 1943, su questo episodio bellico ecco quanto scrive il Generale Emilio Faldella, nella sua “Storia delle truppe alpine”: “ … quella sanguinosa, disperata battaglia che durò, pressoché ininterrotta, per più di trenta ore ed in cui rifulse il sovrumano e sfortunato valore dei battaglioni e dei gruppi della Julia e della Cuneense, che ne uscirono poco meno che distrutti”. … la più dura, lunga e cruenta fra le molte sostenute dagli alpini, sia in linea sia nel corso del ripiegamento.” Alla fine di 30 ore di combattimenti tra il 19 e il 20 Gennaio si stima che oltre 13.000 alpini sono rimasti sulla neve di Nowo Postolajowka.La colonna con il grosso delle divisioni “Cuneense” e “Julia” con i relativi comandi e della divisione di fanteria “Vicenza” continuerà a marciare verso Valujki, originale punto d’arrivo previsto dalle direttive senza essere informata che questa è saldamente in mano all’ Armata Rossa. Ormai sfiancati dopo 12 giorni di marcia e combattimenti , aver percorso circa 200 km in condizioni atmosferiche proibitive, a corto di munizioni e armamento, sovrastati in numero dai russi, la sera del 28 Gennaio gli ultimi sopravvissuti sono costretti alla resa. Pochi sono quelli che in piccoli drappelli riescono a filtrare tra le maglie dei russi e raggiungere dopo altre centinaia di km nella neve nel niente della steppa innevata, le prime ricostituite linee tedesche tutt’ altro che stabili. Più “fortuna” avranno alcuni reparti di retrovia e dei rifornimenti, che attardati dagli attacchi russi durante la marcia verso Postojalvyi, perdono contatto con la loro colonna e si accodano al grosso fiume di sbandati che segue la “Tridentina”, arrivando quindi a Nikolajewka e dove parteciperanno, seppur a ranghi ridotti, alla cruenta battaglia del 26 Gennaio riuscendo così a sfuggire dalla sacca. Solo un piccolo gruppo di reduci riuscì a tornare a Mondovì, il 13 giugno del ‘43, “accolto da un incessante lancio di fiori” come scrisse il foglio fascista “A noi!”. Ma la retorica ormai non poteva più nascondere l’enormità della tragedia né le responsabilità di chi l’aveva provocata. Il pensiero andava ai caduti e alla sorte dei dispersi: angosce rimaste a lungo senza risposta. E da quel settembre ‘43 una parte dei reduci scelse un nuovo generoso impegno sui monti di casa nella lotta di liberazione dall’occupazione nazifascista. Altre dure esperienze, altri sacrifici da non dimenticare.
Favria, 19.01.2022 Giorgio Cortese
Buona giornata. Ci sono persone magnifiche su questa terra che se ne vanno in giro travestiti da normali esseri umani. Felice giovedì
Tannhauser.
Tannhauser è un personaggio presente in molte leggende germaniche e rappresenta l’Uomo in drammatico conflitto tra Spirito e Materia, tra Amore spirituale e Amore carnale. Il libretto su cui Wagner compose la sua Opera, unì a questa leggenda quella di sant’Elisabetta, costruendo così una storia veramente originaleTannhauser è un cavaliere menestrello che vive da lungo tempo sul monte di Venere ammaliato dalla dea, ma desideroso di ritornare alla sua vita di prima. A nulla valgono le suppliche nei confronti di Venere che, alla fine, lo accontenta maledicendolo. Venusberg, in tedesco “monte o montagna di Venere è un luogo mitologico ricorrente nelle tematiche delle tradizioni popolari europee. Si ritrova in varie leggende e racconti epici a partire dal tardo medioevo. Secondo la tradizione germanica le caverne del Venusberg ospitavano la corte di Venere, dea dell’amore. L’accesso alla montagna era nascosto agli uomini mortali, ma il cavaliere Tannhauser, trovatore esistito storicamente e mitizzato, riuscì a raggiungerlo e trascorse un anno in adorazione della dea. Vinto dal rimorso per aver rinnegato Dio, uscì dalla grotta a chiedere perdono al Papa Urbano IV, ma quando l’assoluzione gli fu negata il cavaliere tornò al Venusberg dove rimase per sempre. La leggenda può essere considerata come una variante del mito dell’uomo mortale che, sedotto dalla “Regina delle Fate”, viene trasportato in un mondo ultraterreno. Storie simili si raccontavano già nelle tradizioni popolari e nelle mitologie precedenti, ne sono degli esempi: Oisin nel Tír na nÓg, storia della mitologia irlandese tratta dal ciclo feniano dove si racconta della fata Niamh che innamoratasi del principe Oisin lo porta con sé nel Tír na nÓg, “terra dell’eterna giovinezza”. Dopo tre anni, Oisin decide di tornare in Irlanda, ma Niamh lo avverte che gli anni trascorsi nel frattempo sulla terra erano in realtà trecento, e gli sarebbero piombati addosso non appena avesse toccato terra. La fata dona a Oisin il proprio cavallo, dal quale non sarebbe mai dovuto smontare per nessuna ragione. Oisin trova la sua casa completamente rovinata dai secoli e si appresta a tornare da Niamh, ma durante la strada tenta di aiutare un uomo a sollevare una pietra su un carro causando la rottura delle redini del cavallo. Appena Oisin cadendo toccò terra divenne istantaneamente un vecchio per poi dissolversi in polvere. Thomas Rymer e la Regina di Elfland, racconto e ballata popolare scozzese, trasposta in romanzo durante il Quattrocento: il giovane Thomas si innamora della regina degli elfi che inizialmente lo respinge, in quanto un minimo peccato avrebbe fatto sfiorire la di lei bellezza. Ma l’insistenza di Thomas convince la regina a sposarlo e i due giacciono insieme per sette volte, ma la regina si trasforma in una vecchia decrepita dopo aver dormito con l’amato. Per questo Thomas non potrà più vedere la terra per un anno, e viene condotto nel regno degli elfi. Durante il tragitto verso il regno incantato la regina mostra a Thomas la via del paradiso e la via dell’inferno. Nel regno incantato il giovane trascorre tre o sette anni, che al giovane sembrano solo tre o sette giorni, allietato dal cibo e dalle danze. Al momento di dover partire chiede un pegno in ricordo della regina, che gli conferisce il dono della profezia e lo rende incapace di dire bugie. Egli profetizzerà importanti eventi della storia scozzese. Il nome Venusberg compare per la prima volta nells letteratura tedesca nel nel Formicarius di Johannes Nider, tra il 1437 e il 1438, anni in cui si manifestava un crescente interesse verso la stregoneria. In un passaggio del testo si racconta di un cavaliere che immaginò di recarsi al Venusberg, ma quando si svegliò si ritrovò in un “lago di sterco”. La più antica versione nota della leggenda è riportata dallo scrittore provenzale Antoine de la Sale, in un capitolo dell’opera nota come La Salade del 1440 circa. In questo racconto, basato probabilmente su una tradizione italiana, la “Regina delle Fate” si chiama Sibilla invece che Venere, e non c’è associazione con Tannhauser. La storia racconta che il cavaliere, cercando perdono per aver adorato una dea pagana, venne respinto dal Papa e ritorna perciò nel regno della dea. In seguito il Papa mandò degli emissari per cercare il cavaliere e farlo tornare indietro, senza riuscire più a trovarlo. La narrazione di La Sale si fonde con il nome di Tannhauser nel folclore germanico all’inizio del XV secolo. La ballata popolare germanica di Tannhäuser è attestata da numerose fonti a partire dal 1510 circa, sia in lingua alto-tedesca che in lingua basso tedesca. Versioni popolari erano ancora tramandate nella tradizione orale nella prima metà del secolo XX, specialmente nelle aree alpine, una variante della Stiria chiamata Waldhauser fu trascritta nel 1924. I primi scritti nel 1520 circa, erano riportati su un unico foglio come d’usanza al tempo, e ne sono pervenuti esemplari da Augusta, Lipsia, Straubing, Vienna e Wolfenbuttel. Il primo documento pervenuto è il Lied von dem Danheüser di Jörg Dürnhofers Liederbuch, stampato da Gutknecht di Norimberga nel 1515circa. Questa versione localizza il Venusberg sulle colline di Horselberg vicino a Eisenach in Turingia, sebbene altre versioni identifichino altre ubicazioni. La leggenda rimase popolare fino al XVII secolo, ed è riportata anche da Heinrich Kornmann nel 1614 e Johannes Praetorius nel 1668. La ballata è stata riscoperta con il Romanticismo tedesco. Ludwig Tieck pubblicò la favola nella collezione Romantische Dichtungen del 1799. La versione di Johannes Preatorius del 1668 fu inclusa in Fes Knaben Wunderhorn, una raccolta di poemi popolari tedeschi pubblicati Achim von Arnim e Clemens Brentano nel 1806. Compare anche in forma di riassunto nella collezione Saghe Germaniche dei Fratelli Grimm del 1816. Adattamenti successivi includono la novella Das Marmorbild, la Statua di Marble, 1819, di Joseph Freiherr von Eichendorff, e alcuni lavori di Ludwig Bechstein, 1835 e Ludwig Uhland Volkslieder, 1844. Nel laconico poema di Heinrich Heine Tannhäuser: A Legend, l’eroe trascorre sette anni nel Venusberg prima di recarsi a Roma. Il tema raggiunse la massima popolarità quando Richard Wagner la rimaneggiò e ne riadattò la storia nella sua vasta opera in tre atti Tannhauser, 1845, famosa per la scandalosa raffigurazione della baldoria della corte di Venere nella prima scena. Il poeta inglese Algernon Swinburne racconta la storia in prima persona nel poema Laus Veneris. Anthony Powell la trasforma in una novella: Venusberg. Le “porte di Tannhauser” nel film Blade Runnernel 1982 e nella fiction Cyberpunk fanno riferimento alla leggenda.
Favria, 20.01.2023 Giorgio Cortese
Buona giornata. Certe persone assumono un ruolo al di sopra delle loro possibilità, e così non solo fanno una brutta figura, ma tralasciano anche il ruolo che potevano svolgere. Felice venerdì.
Giornata mondiale degli abbracci .
Tra le tante giornate mondiali che si festeggiano quasi ogni giorno, ecco che il 21 gennaio è dedicato alla “Giornata mondiale dell’abbraccio”. L’abbraccio è uno dei gesti più rappresentativi del calore e dell’affetto umano, che assume un significato ancor più importante in questi anni, quando il contatto fisico per paura del contagio era evitato. La Giornata mondiale dell’abbraccio è stata istituita nel 1986 in Michigan da parte del reverendo Kevin Zaborny. L’obiettivo era quello di alleviare la nostalgia che spesso si prova al termine delle festività natalizie. Questa ricorrenza, dall’America, si è poi gradualmente diffusa in tutto il mondo tramite. Abbracciare non è un semplice gesto fisico, di estensione delle proprie braccia, di apertura verso l’altro, di dono di sé e di accoglienza dell’altro. Abbracciare non è solo un contenere l’altro, una condivisione di emozioni, vissuti, sentimenti. L’abbraccio è molto di più. L’abbraccio di una persona amata lenisce ogni dolore. Come ipotizzato dai ricercatori l’essere abbracciati e accarezzati dalla mamma riduce sensibilmente la durata del pianto dei bambini e i segni fisiologici e comportamentali di risposta al dolore. Ma il bisogno di essere abbracciati non si esaurisce con l’infanzia, e la restrizione dei contatti interpersonali cui siamo stati costretti dall’inizio della pandemia da coronavirus influisce negativamente sulla qualità della vita a tutte le età: basti pensare agli anziani, spesso soli in casa o ricoverati in strutture che non sempre sono organizzate per facilitare l’incontro fisico con i familiari. L’abbraccio è uno dei gesti più significativi che possiamo dare o ricevere per tutta la vita: serve a ricevere o dare consolazione e protezione, a esprimere la gioia del congiungimento o il dolore del distacco, può avere un grande valore erotico o esprimere semplice affetto, può superare le barriere del sesso, dell’età e dello status sociale; può significare amicizia e rispetto ma anche possesso e sottomissione. Ci si abbraccia quando ci si ama ma anche quando si lotta: abbracciare una persona significa certamente riconoscere la sua importanza per noi e coinvolgerla nella nostra fisicità. Durante un abbraccio il nostro corpo reagisce alla presenza dell’altro con una serie di manifestazioni fisiologiche: si innalzano le concentrazioni di ossitocina, ormone che oltre a facilitare il travaglio di parto e l’allattamento favorisce il legame tra le persone e riduce l’aggressività, la pressione arteriosa e la produzione di cortisolo, ormone dello stress, aumentato in caso di depressione, oltre a potenziare l’orgasmo femminile. L’abbraccio aumenta anche i livelli di endorfine, sostanze che riducono la percezione del dolore e inducono una sensazione di benessere. Abbracciarsi guardandosi negli occhi consente inoltre a due persone di sintonizzare il loro stato di coscienza, soprattutto attraverso la stimolazione dell’emisfero cerebrale destro, maggiormente coinvolto nella risposta emotiva e affettiva, rinsaldando così il loro legame. Questo gesto semplice e spesso trascurato o sottovalutato può e deve essere coltivato nelle relazioni interpersonali, anche vincendo la riluttanza o l’imbarazzo, perché fa bene sia a chi lo dà sia a chi lo riceve.
Favria, 21.01.2023 Giorgio Cortese
Buona giornata. Un forte e accogliente abbraccio di condivisione può contenere fraterna amicizia, passione in amore con lacrime di gioiosa felicità, di comprensione e anche lacrime di disperato dolore. Felice sabato.
Lupus, nomen omen.
Nomen omen è una frase idiomatica latina, che può essere tradotta come “Il destino è nel tuo nome”. E il nome dei luoghi può spiegare il destino dei lupi. La denominazione dei luoghi di solito riflette l’uso, le caratteristiche naturali più suggestive, proprietà o particolari eventi storici e molti toponimi hanno come esplicito riferimento ad animali e piante sono stati dati in base a ciò che le persone vedevano nella loro vita quotidiana: possono quindi essere considerati indicatori della precedente presenza di alcune specie. Molti toponimi raccontano la distribuzione passata del lupo, ma anche i sentimenti che le persone provavano nei loro confronti e che non sono tanto diverse da ora, come ammirazione e paura per questo carnivoro e quando questi mammiferi hanno iniziato a sparire alla fine del 1800, i toponimi sono rimasti lì a testimoniare la loro preesistente presenza. Pensate in Italia ci sono circa più di 1.500 toponimi legati al lupo. Un toponimo come Lupara, indica il luogo della cattura del lupo e, più tardi nel tempo, sarà modello specifico di fucile progettato per la caccia al lupo, pare che sia presente nel Patrio Stivale ben 87 volte, poi abbiamo Caccialupo, Monte Lupo, Mazzalupo, Cagalupo, Cecalupo, Scannalupi, Scaccialupo, Fosso del Lupo e poi come non dimenticare il canavesano Pian del Lupo in territorio di Colleretto Castelnuovo. Il lupo ha anche dato origine a dei cognomi personali come Lupi, Lupu, Luppi, Lupelli, Lupini, Luppoli, Lupori, Luporini, Lupone, Lupieri, Lupatelli, Luvotto, Lovato, Lovarini, Lovatelli, Lupatini. Singolare è il cognome Bacigalupo legato al vocabolo dialettale genovese basiga, dondolare, stuzziCare, pesare, e lupo con il significato di dondola, stuzzica, pesa i lupi. Il soprannome indicava probabilmente un cacciatore di lupi che attaccava le pelli a un bastone per trasportarle, da cui il dondolio, o un mercante di pelli di lupo. Ma il lupo ha lasciato molti modi di dire in italiano dal “urli come un lupo”, ovvero molto raramente, una volta ogni tanto. La tradizione popolare vuole che il lupo sia un animale molto silenzioso, che ulula di rado. Oppure dire di aver provato il “morso del lupo”, essere diventati prudenti dopo avere avuto esperienze sgradevoli. Si dice anche aver provato il “dente del lupo” o “aver visto il lupo” per indicare una persona che ha una una voce fioca, tremula, come dopo un grande spavento. Secondo la tradizione popolare, la vista di un lupo è così paurosa che fa perdere la voce. Ed allora stiamo attenti a non “cadere in bocca al lupo”, modo di dire per indicare di non cadere in mano a un nemico o anche di dovere affrontare un grave pericolo trovandoci in una situazione difficile a causa della nostra imprudenza o ingenuità. Sicuramente non è mia intenzione fare il lupo pecoraio, ovvero fare qualcosa che non è assolutamente nella mia umana natura, come tramare un inganno da cui trarre profitto, così come farebbe un lupo che decidesse di diventare pecoraio. Questo simpatico modo di dire deriva da una favola di Verdizotti e poi ripresa da La Fontaine. E vuole anche dire nell’affidare un bene prezioso alla persona meno adatta, di cui si dovrebbe invece diffidare, come se si assumesse un lupo per far la guardia alle pecore. In senso lato, essere imprudenti, sventati o molto ingenui. Una sistuazione spiacevole è quella di “tenere il lupo per gli orecchi”, modo di dire per indicare quando ci troviamo in una situazione precaria, in condizioni di equilibrio instabile, nella quale non si possiamo resistere a lungo e che al minimo cedimento potrebbe volgere al peggio. Questo era un detto proverbiale già in epoca romana, usato da Svetonio nei confronti dell’imperatore Tiberio e da altri autori, tra cui Terenzio: “Tengo il lupo per le orecchie, e non so né in che modo mandarlo via né come tenerlo fermo. Purtroppo oggi corriamo il rischio di mettere il lupo nell’ovile, modo di dire per indicare di mettere qualcuno in una posizione di grande vantaggio anche se poi si dimostra incapace, dandogli la possibilità di nuocere a tutti, come ponendo un lupo all’interno di un ovile. Ma le persone capaci esistono ancora anche se sono oggi come allora delle lupe bianche, per dire che sono molto rare. Una curiosità il museo parigino del Louvre pari derivi dal latino lupara, cioè “luogo abitato dai lupi”, anche se altra ipotesi potrebbe derivare da un termine francone leour, che significa castello, terza ipotesi potrebbe derivare dal lemma rouvre, che significa quercia, e che si riferisca al fatto che era stato costruito in un bosco di querce. Beh in questi giorni il clima freddo ci porta ad esclamare: “un tempo da lupi!”, ed allora forse è meglio che smetta di “gridare al Lupo”, come nella famosa favola di Esopo, ed accomiatarmi con l’augurio di in bocca al lupo! Con la vostra puntuale risposta: “crepi il lupo!”.
Favria, 22.01.2023 Giorgio Cortese
Buona giornata. Viviamo per raccogliere la bellezza del mondo per donarla a chi abbiamo accanto questa è la nostra quotidiana missione. Felice domenica
Giovare la giovenca, il manzo ed il bue.
Molti forse ignorano che il Bosforo, lo stretto che unisce il mar Nero al mare di Marmara e che segna, assieme allo stretto dei Dardanelli, significa passaggio o guado della giovenca dalle parole greche buos, vacca e poros , passaggio e allude al mito secondo il quale Zeus, a causa di un incantesimo gettato da Iunge, figlia di Pan e di Eco, si innamorò di Io. Ma, poiché temeva la gelosia di Era quando la andava a trovare, la nascondeva in una nuvola dorata. Era lo accusò di infedeltà e trasformò Iunge nel volatile torcicollo, che da lei prese il nome e che, anticamente, era venerato per gli esorcismi amorosi. Secondo altre fonti, la dea tramutò Iunge in una statua di pietra. Zeus negò: “Non ho mai toccato Io” e per evitare di essere scoperto trasformò la giovane in una giovenca bianca. Ma Era ne reclamò la proprietà e la affidò ad Argo Panoptes, Argo che tutto vede, ordinandogli: “Lega segretamente questa vacca a un albero di olivo presso Nemea”. Ermes, incaricato da Zeus di recuperare Io, prima addormentò Argo, poi lo uccise colpendolo con una pietra ed infine tagliandogli la testa. Così liberò la giovenca. In seguito Era mandò un tafano a pungere Io, che cominciò a correre per tutto il mondo conosciuto per sfuggire all’insetto. Arrivata al braccio di mare tra Europa e Asia, attraversò a nuoto lo stretto, che prese il nome di Bosforo, ed infine giunse in Egitto, dove partorì Epafo, riacquistando le fattezze umane. Il mito parla di una giovenca dal latino iuvenca, giovenco nella forma maschile, per indicare una vacca giovane. Troviamo questo vocabolo in Quasimodo: “Giovenca guardando il cielo aspira avida l’aria”. Nella versione maschile abbiamo un verso del Carducci; “ De’ bei giovenco dal quadrato petto”, ed in senso letterale uomo o ragazzo giovane vigoroso, per la versione femminile una giovane donna dall’aspetto florido. Ma allora la parola manzo cosa vuole dire. Il manzo è una carne di bovino, in genere maschio castrato, macellata tra il terzo ed il quarto anno di età. Il manzo può essere anche ottenuto da mucche, tori e giovenche. Il bovino macellato entro il primo anno di vita viene invece chiamato vitello. La parola manzo deriva dal latino mansuetus, reso docile dalla castrazione. Una persona di grossa corporatura, pesante nei movimenti, o d’aspetto rozzo viene detto manzo. La parola bue significa in senso stretto, maschio castrato della specie, bos taurus, della famiglia dei bovini; designa anche, più impropriamente, la specie nel suo complesso. La parola latina bos, in origine indicava sia il maschio castrato sia la femmina. È quasi imbarazzante la quantità di vocaboli di cui disponiamo per i bovini. Li distinguiamo per sesso, età (il manzo è più vecchio del vitello ma più giovane del bue) e stato civile: se un maschio è votato al celibato è un bue, in caso contrario è un toro; una madre di famiglia è una vacca, una fanciulla che non ha mai partorito è una giovenca. “Mucca” è un soprannome forse modellato sul suono “mu”, da cui per inciso provengono anche “muto” e “motto”. Il mutismo infatti implica l’incapacità di esprimersi se non per suoni inarticolati, e “motto” indicava appunto uno di questi suoni, benché le piroette della lingua l’abbiano poi portato a significare “parola” (come nel francese mot) e quindi “battuta”. Curiosamente però ci manca un nome complessivo per la specie, per cui dobbiamo rassegnarci a parlare di bovini o buoi domestici, anche se uno è un termine troppo generico e l’altro troppo specifico. In questo senso possiamo dire che i buoi si annidano dovunque, a partire dai modi di dire: mettere il carro davanti ai buoi, tagliare la testa al toro, andare in vacca… Quest’ultimo in particolare nasce da una metafora dei produttori di seta: se i bachi, ammalandosi, si gonfiavano come vacche, la rovina era segnata. Ma lo zampino bovino c’è anche in parole insospettabili. Settentrione viene da septem triones, ossia sette buoi da lavoro, giacché a nord brillano le sette stelle del Piccolo Carro. la citta di Oxford significa “guado dei buoi”. L’Italia stessa, secondo un’antica teoria, deriverebbe dal latino vitulus, vitello, forse per i suoi fiorenti allevamenti o per il diffuso culto d’un dio bovino. Più contrastata, ma comunque possibile, è l’ipotesi che tori e buoi abbiano dato il nome alle tribù celtiche dei Taurini e dei Boii, e quindi alle città da loro fondate: Torino e Bologna.
Purtroppo ai bovini sono legate anche parole inquietanti, come ecatombe. festa di primavera nell’Antica Atene con il sacrificio di cento buoi, bulimia, fame da bue, boia che in latino significava laccio, gogna, per estensione strumento di tortura e successivamente lo stesso carnefice; a sua volta dal greco, boieai strisce di cuoio di bue, con cui erano fatti i lacci e le fruste. Rientra in questo gruppo “bulldozer”, nata in America nel 1876 per definire i più violenti sostenitori del democratico Tilden, che usavano dispensare frustate in “dosi da toro”, bull dose, contro gli elettori neri per tenerli lontani dalle urne o per intimidirli a votare democratico. La parola diventò quindi un sinonimo di “prepotente” e infine il nome d’un implacabile veicolo apriprista. Ben più affascinante, tuttavia, è il fatto che la prima lettera dell’alfabeto ricalchi la forma di una testa bovina: perciò era detta aleph, “bue” in fenicio. E spesso i bovini hanno offerto anche il supporto materiale della scrittura, ossia la pergamena. Un tipo particolarmente pregiato era detto papier vélin, “carta di vitello” in francese; poi “velina” si è esteso a definire un qualunque foglietto dattiloscritto, e quindi le vallette che consegnavano agli annunciatori televisivi le notizie da divulgare. Non solo: il primissimo esempio di italiano scritto o meglio di latino italianizzato è l’indovinello, che paragona la scrittura all’aratura d’un campo per mezzo di buoi. Preparava i buoi, arava dei bianchi prati e teneva un aratro bianco, nero seme seminava. Le dita della mano sono i buoi, le pagine i prati bianchi, la penna d’oca è l’aratro e l’inchiostro il nero seme. La soluzione è la mano che scrive, l’atto di smuovere le idee per renderle fertili e permettere al testo di essere raccolto dal lettore. Del resto il menabò, che in gergo tipografico è il modello di partenza per l’impaginazione di un libro o rivista, significa proprio “conduci (mena) i buoi (bò)”. Insomma, che si parli di luoghi reali o di avventure libresche, all’origine dei nostri viaggi c’è sempre un bue.
Favria, 23.01.2023 Giorgio Cortese
Buona giornata. Coloro che sono stati visti danzare erano ritenuti pazzi da coloro che non potevano ascoltare la musica. Felice lunedì.